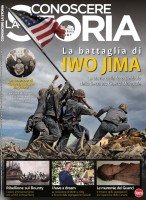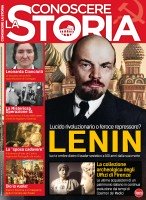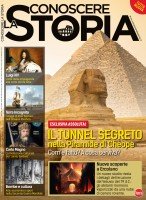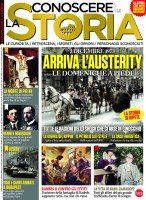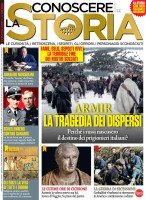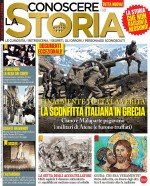Abbonati alla rivista
Conoscere la Storia
Informazioni su Conoscere la Storia
Dagli autori di All about history, prestigiosa rivista inglese di storia, ecco la versione italiana integrata di tanti nuovi contenuti relativi al panorama italiano.
Abbonati a Conoscere la Storia con la Carta del docente
Carta del Docente è un buono del valore di 500 euro assegnato ai docenti
di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali.
Cartadeldocente.istruzione.it è l'applicazione web che permette ai
docenti di spendere l'importo assegnato utilizzando Buoni di spesa
elettronici per i beni o i servizi previsti dal servizio.